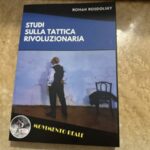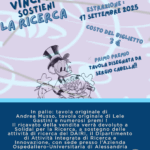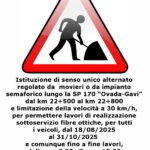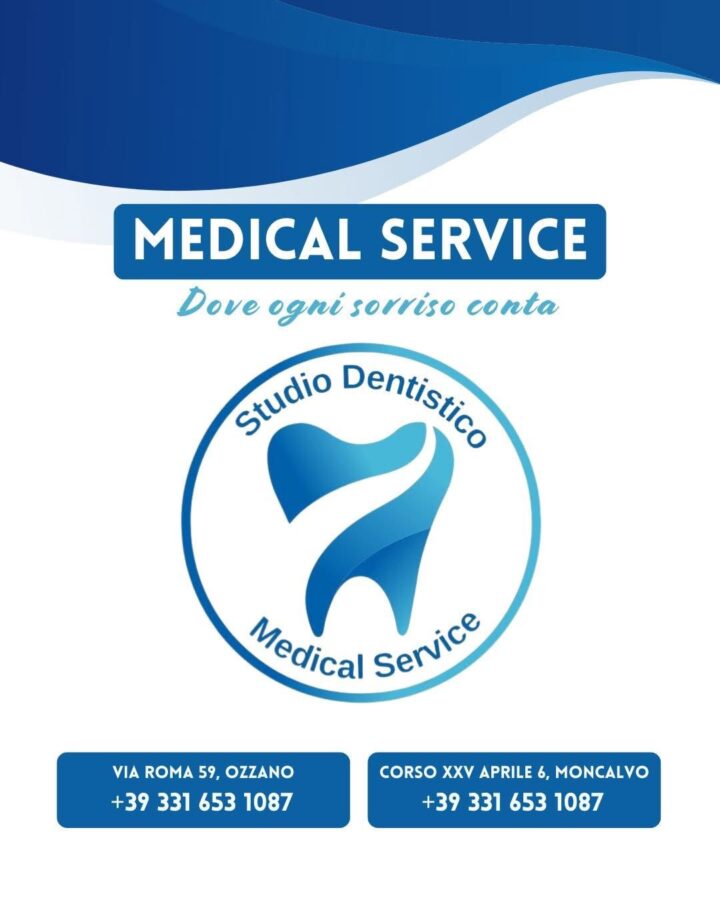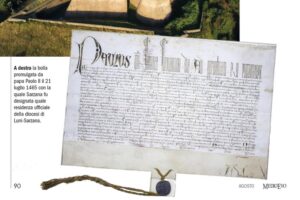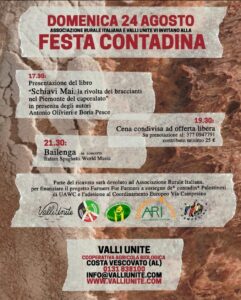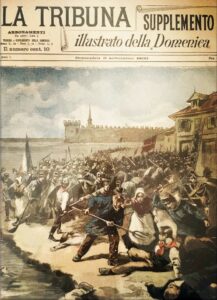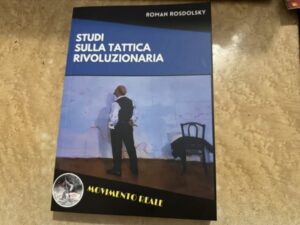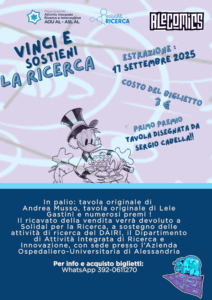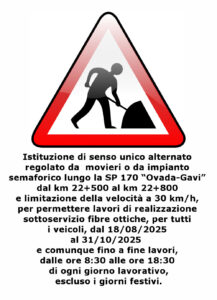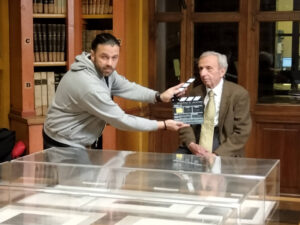Viaggio nel Medioevo, il Castello di Graines
di Chiara Parente

Degne dell’ambientazione di un romanzo gotico, le romantiche rovine del castello di Graines, in
prossimità dell’omonima borgata di Brusson, sovrastano un roccione a 1332 metri di quota, nel
limite fra la Bassa e l’Alta Val d’ Ayas (Aosta), suscitando la curiosità di chi le osserva.
Parecchie le domande che nascono spontanee. Quanto può essere antica quest’architettura difensiva,
dalla fisionomia assai diversa rispetto a quella dei ben più noti castelli valdostani? Perché costruire
un poderoso presidio militare in una zona tanto lontana dalle attuali direttrici viarie? E ancora chi e
che cosa doveva proteggere?
Quella del castrum sancti Martini, com’è indicato il baluardo nei documenti d’archivio, e del
mandement de Grana, ossia del feudo di Graines che riprende la denominazione dal maniero, è una
vicenda complessa e poco conosciuta, ma di assoluta importanza sovraregionale, poiché proprietaria
del villaggio fortificato dal XI al XIII secolo fu la ricca e potente abbazia di Saint-Maurice
d’Agaune, nel Vallese svizzero.
Sebbene le fonti scritte citino il castello di Graines solo dal 1263, anno in cui il Visconte di Aosta
Gotofredo fece la prima ricognizione al feudo, e i dati archeologici a corredo siano piuttosto esigui,
la sua erezione, in una località probabilmente già occupata nella tarda età del Bronzo (XI-X sec. a.
C.), rimanda al Mille. Tale datazione concorda con le testimonianze, desunte dai siti valdostani di
Cly e Quart, inerenti all’iniziale fase di incastellamento avviata nella regione e trova supporto nei
rapporti, creatisi nel corso dell’altomedioevo, tra l’abbazia vallesana e il potere regio, borgognone
prima e sabaudo poi.
Infatti, molto probabilmente, la corona borgognone sviluppò la tendenza ad amministrare e gestire
come propri i beni immobili dell’abbazia, molti dei quali situati in territorio valdostano. Tali
possedimenti, identificati nelle fonti come “terra sancti Mauricii”, scompaiono più o meno
improvvisamente alla metà dell’XI secolo, epoca dell’ascesa di Umberto Biancamano. Di
conseguenza si ipotizza che anche la corona sabauda si sia ampiamente servita di questi beni,
utilizzandoli per allargare la propria base fondiaria in Valle d’Aosta, mischiando proprietà private
dell’alta aristocrazia, beni fiscali e terreni di proprietà monastica, grazie al controllo diretto
sull’episcopato aostano e sul centro abbaziale nello Chablais.
Successivamente, in un periodo di debolezza della presenza comitale, la famiglia dei Visconti di
Aosta, futuri Challant, a sua volta si appropriò di questi possedimenti, ormai divenuti fiscali, senza

tuttavia perdere del tutto la memoria di un loro possesso a nome dell’ente abbaziale, fino alla
richiesta di una ricognizione formale, avvenuta nel caso di Graines verso la metà del Duecento,
periodo a cui risalgono le prime attestazioni scritte.
Le motivazioni all’origine dell’impianto fortificato di Graines e dell’interesse nutrito nei suoi
confronti dal potere regio emergono attraverso l’analisi della cartografia, da cui si evince la
centralità della circoscrizione che aveva in Graines il proprio fulcro amministrativo. Essa
comprendeva la parte superiore della Valle d’Ayas con una porzione di quella del Lys, territori oggi
facenti parte dei Comuni di Ayas, Brusson, Challand-Saint-Anselme, Gressoney-La-Trinité e
Gressoney-Saint-Jean. Un’area estesa dalla confluenza dell’Evançon con la Dora fino alle pendici
del Monte Rosa, sul confine con la Svizzera vallesana, oggi valicabile tramite sentieri percorribili
solo nella stagione estiva.
Nel Medioevo una fitta rete di percorsi, adesso di difficile lettura, collegava il mandement a nord
con il Vallese attraverso il Colle del Teodulo, a est con la Valle di Gressoney, la “Lombardia” e il
milanese tramite il Col Ranzola, a ovest con Saint-Vincent e l’alta Valle d’Aosta mediante il Col di
Joux e a sud, seguendo la via lungo il corso dell’Evançon, al borgo di Verrès e alla Bassa Valle.
Pascoli e foreste dalla sicura resa agricolo-pastorale si estendevano da nord a sud del comprensorio,
mentre nelle alture più elevate torri di guardia e strutture difensive controllavano il passaggio di
persone e merci.
Il castello di Graines, tra gli esempi di architettura romanica castrense di maggior pregio e antichità
nella regione, si presenta come un tipico castello-recinto, in cui i fabbricati sono disposti entro una
cinta, che protegge un’emergenza naturale di 2000 m².
Isolato su tre lati da un salto di quota, il villaggio fortificato si raggiunge solo a ovest.
Lasciata l’auto in uno slargo ai piedi del promontorio, si sale un’erta mulattiera che, faticosamente
ricavata da una scoscesa parete rocciosa, regala panorami mozzafiato sulla vallata.
Una porta ad arco a tutto sesto, alta 2,2 metri e larga 1,5 metri, ornata con ghiera e stipiti in conci di
pietra verde, una ofiolite locale ricorrente nelle pareti in posizioni di particolare rilevanza formale,
immette in un avancorpo appoggiato alle mura.
Ritenuta uno degli elementi più antichi del castello, insieme alla torre merlata e alla cappella, la
cinta, costruita con materiale di medie e piccole dimensioni disposto a tratti a spina pesce in tre
distinte fasi, collocabili a cavallo dei secoli XI-XII e XII-XIII e nel corso del ‘200, è sormontata da
una corona di merli pseudotrapezoidali di dimensioni rilevanti (tra i 120 e i 170 cm), separati da
intermerli di ampiezza più limitata (ca. 70 cm).
Qualche passo separa il principale portone d’accesso da un secondo portale. Identico al precedente

per dimensioni e fattura, esso è munito di feritoie rivolte verso l’esterno, dotate di una nicchia di
tiro strombata ricavata nello spessore del muro e, attraverso la cortina occidentale, immette
nell’area del castrum.
All’interno del millenario recinto le infinite sfumature grigioverdi delle rovine paiono confondersi
in un tutt’uno con quelle del meraviglioso paesaggio alpino che le incornicia, mentre al di sopra,
ovunque, domina l’azzurro del cielo. Un silenzio misterioso, quasi innaturale, ricorda che questi
resti, pieni di storia, otto-nove secoli fa, sono stati un mastio, una chiesa, un focolare.